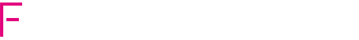Due chiacchiere con Benedetta Barzini e Beniamino Barrese
La parola “autenticità” ricorre a cadenza regolare in una conversazione con Benedetta Barzini e Beniamino Barrese. I due non sono solo madre e figlio ma anche regista e protagonista de La scomparsa di mia madre, il documentario, selezionato dal Sundance 2019 nella sezione World Cinema Documentary e uscito nelle sale lo scorso 10 ottobre.
Rispondere alla domanda sui motivi della riuscita del film con «perché è intriso di autenticità» sembra un artificio ma basta vedere la loro alchimia, il loro spalleggiarsi, il loro proteggersi l’uno con l’altra per capire che quello che hanno avuto il coraggio di mostrarci sul grande schermo corrisponde a verità. Li abbiamo incontrati in Fashion Research Italy e abbiamo approfondito con loro alcuni temi emersi nel film che si incrociano con l’attività di formazione e ricerca che la Fondazione persegue per approfondire i vari ambiti in cui si articola il mondo della moda.
E’ un lavoro tutt’altro che semplice: si tratta di un figlio che si trova a fare i conti con il desiderio della madre di andarsene in un luogo lontano e indefinito, stanca di dover fare i conti con tutti i ruoli che si è trovata a ricoprire nella vita. Prima modella italiana a comparire nel 1963 su Vogue America per volere della leggendaria fashion editor Diana Vreeland, Benedetta Barzini è stata ritratta da Richard Avedon e Irving Penn, musa di Andy Warhol e Dalì, femminista militante, giornalista e docente universitaria oltre che madre di quattro figli e ora nonna, solo per citarne alcuni.
Sciorinando nomi, incontri ed esperienze noncurante degli occhi sgranati del suo interlocutore, solo di fronte a una di queste numerose tappe della sua esistenza fuori dall’ordinario, qualche lacrima le bagna gli occhi. Quando racconta i suoi anni da insegnante. La sua specialità è la storia dell’abito e l’antropologia della moda, una materia che maneggia con sapienza e che ha trasmesso con passione ai suoi studenti.
Nel film la vediamo in aula. Come è stato insegnare?
Quando penso ai miei studenti, mi commuovo. Io insegno una sola e unica cosa: a osservare. Che siano vestiti, scarpe o cappelli io voglio che i miei allievi si chiedano il perché delle cose. In questo modo io posso capire dove uno si piazza e in quale modalità vuole lavorare nel settore della moda. Questo si può fare seriamente solo se si capisce che la moda è qualcosa in più, che è legata alla sociologia, alla storia, all’antropologia, all’economia, alla politica e anche alla religione. Senza tutto questo è solo foggia o costume. I ragazzi devono studiare e cercare di rispondere a certe domande, è troppo facile criticare: chi lo fa deve proporre un’alternativa, altrimenti non vale.
La moda è una cosa seria.
Quello che la gente si ostina a non capire è che attraverso gli abiti puoi leggere il mondo in cui siamo. È un modo per capire come si esprime la società. Perché l’uomo indossa il cilindro? Perché è il suo tacco, un modo per essere sempre il più alto. Oggi potremmo parlare dell’inganno del «genderless» che altro non è che una questione di marketing: pare si parli di uguaglianza dei sessi quando invece è la donna che indossa indumenti con un’aura maschile, non è l’uomo che mette il reggiseno.
Il film l’ha avvicinata di nuovo alle giovani generazioni?
Molte ragazzine mi hanno ringraziato perché ho dato loro un sacco di spunti su cui riflettere. In realtà è stato bello incontrare anche un sacco di vecchiette che mi hanno abbracciato perché finalmente avevano trovato qualcuno che la pensava come loro, solo che a volte non hanno il coraggio di dirlo. Quella che sembrava una storia privata ha parlato a persone di tutti i tipi e questo mi commuove molto. L’importante è non iconizzare nessuno: l’errore sta nel pensare che qualcuno sia speciale. Non è così, lo siamo tutti.
Se dovesse suggerire un libro ai corsisti di FRI che vogliono intraprendere un percorso nella moda, quale sarebbe?
Non ho dubbi: Questione di sguardi di John Berger, un volume fondamentale per allenare lo sguardo. E chi si avvicina a questo mestiere, lo dicevamo prima, deve assolutamente imparare a farlo.
Per Beniamino Barrese questo è il primo lungometraggio come regista. È nel mondo del cinema e delle produzioni video dal 2011, nascendo come fotografo. Ora è in tour con il film distribuito in Italia e presto negli Stati Uniti e sta cominciando a mettere insieme gli elementi che andranno a comporre il suo futuro in questo settore.
E’ nata prima la passione per il documentario o la voglia di raccontare sua madre?
Quello per mia mamma è un interesse che ho da sempre. È la prima persona che ho visto, mi è venuto spontaneo cominciare da qui. Ho sempre sentito la responsabilità di comprendere e raccontare quello che viviamo e questo mi avvicina molto al documentario. Parlare di lei mi ha permesso di affrontare moltissime questioni legate anche alla mia generazione. È un lavoro quindi molto meno personale di quello che potrebbe sembrare ed è stato bello sapere che per molte persone abbia significato tanto.
Come è stato parlare del vostro rapporto in un film?
Quando l’ho girato, pensavo che sarebbe stato rivolto ad una nicchia che ama il genere. Poi ha funzionato molto bene soprattutto per il carisma del personaggio ed è uscito da certi circuiti approdando nei cinema. Questa parte è stata finora la più difficile: non tutti sanno cosa sia un documentario e ignorano che c’è anche qui la costruzione di un personaggio e una drammaturgia.
Quali sono gli aspetti a cui ha dovuto dedicare più attenzione?
Ho lavorato molto sulla luce. Ho studiato come direttore della fotografia e creare l’illusione della luce realistica può essere più complicato che ricreare una luce artificiale. In certi casi, ho creato una tensione drammaturgica raccontando cose non vere e anche sul montaggio sono intervenuto ricreando le scene come le volevo io. C’è un lavoro di scrittura, non è un reality show.
Ora cosa vede nel suo futuro?
Questo film mi ha dato la forza di intraprendere questa professione anche se so che sarà complicatissimo vivere di questo. Non vedo l’ora di buttarmi su un altro progetto, mi piacerebbe avere tra le mani la sceneggiatura di un film di finzione ma non escludo di continuare con il documentario. Per me i generi sono molto uniti, l’importante è sempre raccogliere qualcosa di autentico.
Ma sua madre alla fine questa voglia di scomparire ce l’ha davvero?
Non lo so. Ora si è riaccesa anche grazie all’incontro con il pubblico. Non tanto per il palcoscenico quanto per ricreare quel rapporto che aveva con i suoi studenti. Penso che quel desiderio sparirebbe se potesse tornare a fare quello che le piace e che la appassiona così tanto. Mia madre è una vera maestra e, al di là di quello che insegna, può davvero cambiarti la vita.